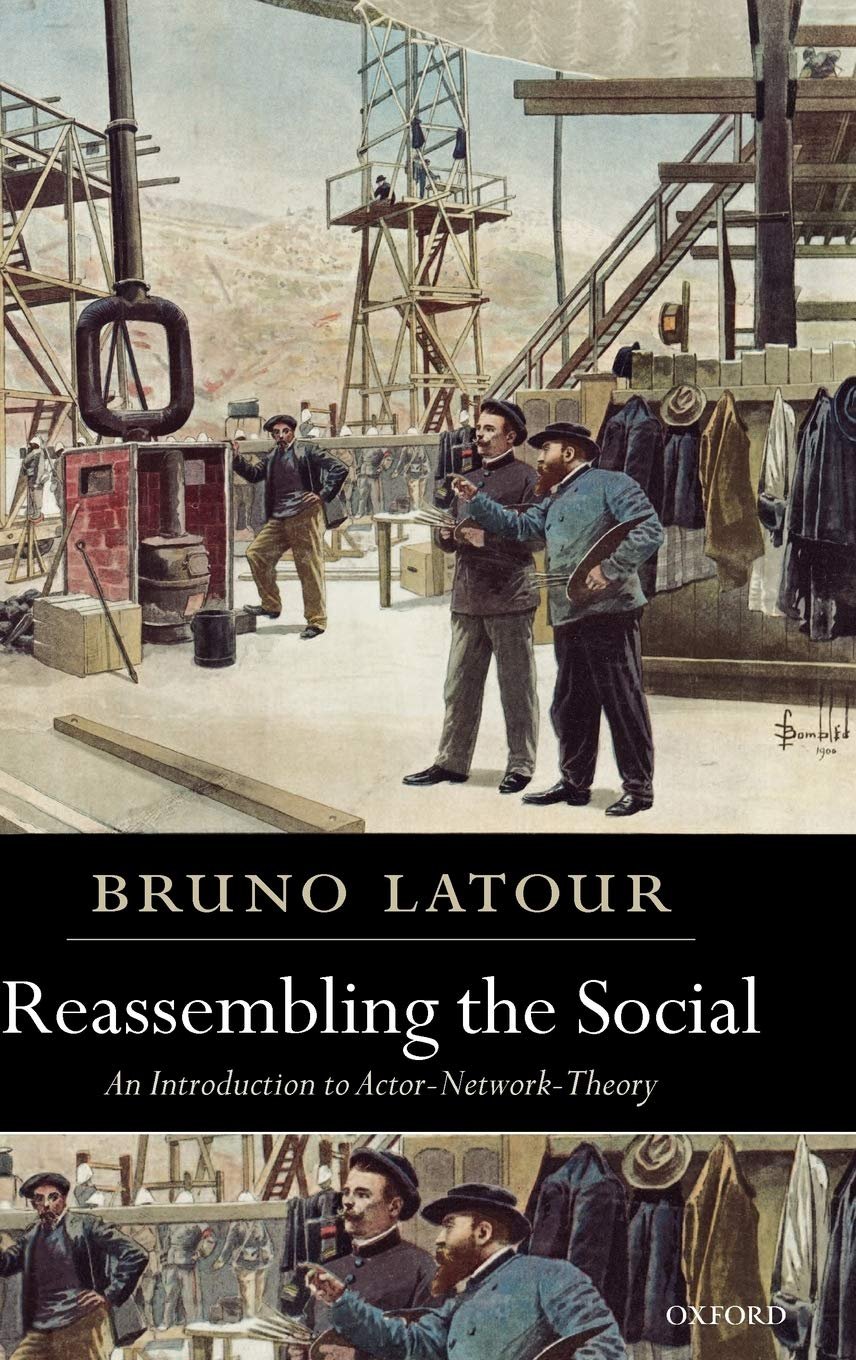Arte, fatti, artefatti.
Mi ero scordato di questo video, che produssi perché non essendo (nemmeno all’epoca) dotato del dono dell’ubiquità non avevo potuto partecipare a un evento sul design cui, del tutto immotivatamente, ero stato invitato.
Era un tempo quello in cui ancora facevo cose che non faccio più (senza aver letto DFW, mi ha sempre affascinato l’idea di cominciare a fare cose ma molto di più l’idea di smettere di farle, come in tempi più recenti ci ha ricordato in un monumentale episodio di Vergini il mitico Jacopo Romei). Qui non si parla di arte dello smettere (art of quitting?) ma di come viviamo immersi in una sistema di riferimenti (forse si dice semiosi) in cui umani e non umani non sono sostanzialmente distinguibili.
Gli umani - noi - interagiamo sia con elementi a noi esterni (viventi o inerti, comunque naturali) sia con ciò che è frutto della nostra invenzione: una volta che dall’arte (etimo dubbio, ma si rifà a qualcosa che c’entra con il movimento, l’attivazione) passiamo all’artefatto, l’intento con cui l’abbiamo fatto diventa in un certo senso indipendente da noi, eccedendo, sorprendendoci. E noi entriamo in dialogo con quella cosa (TBC).
Note to self: rileggere “La caffettiera del masochista”.
Ed ecco il video: è di sei anni fa. Qui la versione testuale.
“Progettare un artefatto - qualunque cosa, dalla forchetta al piano provinciale delle estrazioni minerarie - significa prevedere come verrà hackerata nell’uso. Significa prevedere quell’incidente nel futuro di cui parla Paul Virilio. Progettare l’interazione significa prevedere l’uso, l’abuso e il mancato uso del mondo come atti fondativi del nostro essere umani.”
Di quella volta che raccontai di come con gli oggetti della progettazione si deve entrare in relazione. Perché sono parte della nostra vita.
Imperdibile saggio che attualmente sto leggendo (insieme ad altre decine).
E quello da cui tutto origina.